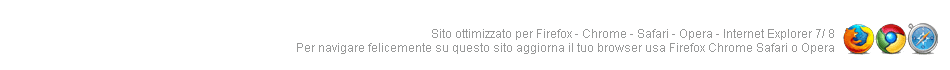«Cerco una stanza per parte della notte, perché non trovo più la mia». (Bernard-Marie Koltès)
Straniero in patria: provo a mettere insieme questi due concetti evidentemente inconciliabili, ma non ci riesco. Il loro accostamento è un paradosso, un errore, una possibilità altra che sgretola il senso delle singole parole. Come si può essere straniero in patria? È come dire che la propria patria ci è estranea. È come affermare di essere stranieri a se stessi. È qualcosa di indicibile, che tuttavia esiste, c’è. Penso al monologo di Koltès e a quante volte le parole “straniero” o “estraneo” vengono pronunciate: tante, troppe, come una pioggia incessante. Eppure il loro significato è chiaro, esplicito, scritto e detto per quello che è, Nella sua feroce evidenza. “Straniero in Patria” è un ossimoro, un’espressione Nata per giustificare un’assenza, un malessere. È una questione che riguarda l’identità, “quel pezzetto di carta Plastificato chiamato carta di identità”. La Nostra identità si costruisce attraverso lettere, numeri e codici che hanno una data di scadenza.
Giunti a quel termine cosa ci accade? Quando l’ora fatidica scatta non è solo il documento a scadere ma anche noi. Quel pezzo di carta segna la nostra fine, fino al successivo rinnovo è come se non esistessimo. Questo ci accade nella nostra patria, ma ancora di più quando viviamo in un paese straniero, in attesa di un’adozione sempre e comunque dolorosa. Dolorosa perché bisogna provare agli altri il proprio diritto ad esistere, spingendoci a dimostrare a noi stessi il nostro diritto alla vita. Solo con quel pezzetto di carta la nostra esistenza è perfetta, non mutilata. Solo con quel documento a scadenza decennale siamo delle persone o meglio simboli di persone, con il proprio diritto a crescere, esistere, procreare, morire. E lavorare. «[…] ti fanno sloggiare a calci in culo, il lavoro è laggiù, e poi ancora laggiù, sempre più lontano. […] Se vuoi lavorare, sloggia. […] il lavoro sta sempre da qualche altra parte e non potrai mai dire: sono a casa mia […]. Ogni volta che me ne vado da un posto, ho sempre l’impressione che fosse casa mia più di quanto potrà esserlo quello in cui vado, e quando ti pigliano a calci in culo un’altra volta e te Ne vai di Nuovo, Nel posto in cui vai sarai ancora più estraneo, sempre meno a casa tua». Afferma Koltès.
Lavoriamo, produciamo, quindi esistiamo. Ma il lavoro è altrove, bisogna cercarlo da un’altra parte. Siamo sempre costretti a partire. Quando non siamo d’accordo, quando cerchiamo di innescare un meccanismo di rottura per trovare nuove vie, quando cerchiamo di rompere l’identità di un luogo per ricrearne una Nuova ed essere Noi stessi luogo senza subirlo… è allora che chi ti ha voluto fino a quel momento, ti allontana, facendoti sentire uno straniero in patria. Dietro di te c’è il deserto, davanti una Nuova solitudine. Ma «la solitudine del diverso, dello straniero» (come dice Koltès) può avere anche una valenza positiva, almeno per me, che forse ho sempre rincorso la naturale condizione di “essere straniero”. Deve averla. È in questa condizione che si può trovare un Nuovo modo di stare nelle cose di tutti i giorni, soprattutto quando si ha il coraggio di sradicarsi al punto di diventare stranieri non solo agli altri, ma prima di tutto a se stessi. È in questa solitudine che occorre allontanarsi da ciò che consideriamo riconoscibile, o meglio, da ciò che Noi identifichiamo come conoscibile, e confrontarsi con un Nuovo “Noi”: per conoscersi e non per riconoscersi, per trovarsi e non per ritrovarsi. Essere straniero in patria ci permette di sfruttare il fatto di non essere capiti soprattutto da noi stessi per cercare Nuove lingue. E con queste nuove lingue parlare e parlarci come forse non abbiamo mai saputo fare. In definitiva, credo che la possibilità di essere straniero in patria possa essere per molti di noi una condizione rigeneratrice, liberatoria, finanche necessaria per non farci uccidere prima del tempo naturale delle cose.
Antonio Latella